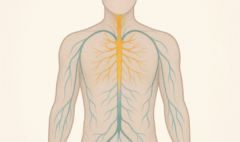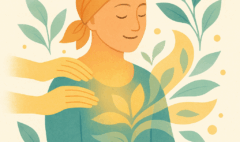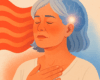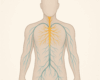Dal Passato al Futuro della Disfunzione Somatica: Sfide e Opportunità nella Ricerca Osteopatica
Dal Passato al Futuro della Disfunzione Somatica: Sfide e Opportunità nella Ricerca Osteopatica
Dalla “Lesione” alla Disfunzione Somatica
Nel 1874 Andrew Taylor Still, il fondatore dell’osteopatia, sviluppò la teoria che i processi patologici si verificassero nel momento in cui un ostruzione ostacolava la libera circolazione dei fluidi o, più poeticamente, il “flusso della vita”. Grande studioso di anatomia, affascinato e in parte forgiato, dal periodo di Rivoluzione Industriale che stava vivendo, amava paragonare l’uomo ad una macchina e l’osteopata a un “attento meccanico” in grado di correggere gli strain e gli stress attraverso la manipolazione, in modo che la salute potesse riemergere. Diede il nome di “lesione” alle anormalità strutturali oggetto dei suoi trattamenti, in una visione apparentemente meccanicistica in quanto la diagnosi veniva fatta a partire dalla conoscenza dei corretti rapporti articolari e dalla rilevazione delle aree in cui tali rapporti non erano ottimali. Negli anni successivi i suoi allievi continuarono a riferirsi a queste aree con il termine “lesione osteopatica” che venne poi successivamente sostituito da “ disfunzione somatica” per distinguerla dalle lesioni anatomiche e sottolinearne la natura funzionale.
Le Prime Ricerche sulla Disfunzione Somatica
La ricerca in merito a quali fossero i meccanismi sottostanti la genesi e il suo mantenimento nel tempo sono iniziati nel 1907 ad opera della dottoressa Burns, che dimostrò sul coniglio che i muscoli e le articolazioni in cui era stata prodotta una disfunzione somatica vertebrale, se confrontati con livelli vertebrali sani, presentavano alterazioni vascolari come microscopici stravasi di sangue, infiammazione ed edema (Burns 1907) .
Il Modello Neurologico di Denslow e Korr
Denslow e Korr a partire dal 1947 gettano le basi del modello neurologico della disfunzione somatica. Chiariscono il rapporto segmentale della disfunzione vertebrale con il neuromero di riferimento, rilevando sia un abbassamento della soglia del riflesso motorio all’elettromiografia, che un alterazione dell’attività simpatica segmentale (Denslow at al. 1947).
L’attivazione simpatica periferica e la disfunzione somatica rilevate afferivano allo stesso segmento midollare (Korr at al. 1962, Korr 1975).
Se si anestetizzava il processo spinoso non si riusciva più a evocare il riflesso motorio, ma se la pressione veniva esercitata su altre spinose, i muscoli interspinali di questi segmenti erano i primi ad attivarsi e gli ultimi a rilassarsi una volta interrotto lo stimolo (Denslow at al. 1947). Tale attivazione è stata rilevata anche in risposta a: rumori improvvisi, domande imbarazzanti, comunicazione di false cattive notizie, in pratica agli stress quotidiani a cui ognuno di noi suo malgrado è sottoposto.
Korr definisce questa sensitizzazione, modello del “segmento facilitato” a carico della zona disfunzionale e ipotizzò che l’ipereccitabilità dei motoneuroni nei livelli disfunzionali dipendesse dalle informazioni afferenti provenienti dai fusi neuromuscolari, imputando all’eccitazione dei motoneuroni γ la permanente e dolorosa contrazione muscolare da lui riscontrata. Tale concetto è molto simile a ciò che oggi viene definito “sensitizzazione periferica”: l’abbassamento della soglia di un recettore in risposta a uno stimolo mantenuto nel tempo, che determina di fatto la risposta esagerata del recettore a stimolazioni che normalmente non sarebbero in grado di attivarlo.
Nuovi Modelli di Comprensione
Successive ricerche hanno poi smentito la presenza di questo “tono γ”, il segmento facilitato si manifesta come una serie di riflessi nocicettivi e infiammatori che causa diverse alterazioni, quali l’atrofia dei muscoli profondi spinali come il multifido, l’eccitazione dei muscoli polisegmentari come l’ileocostale e il lunghissimo e un attivazione cronica del simpatico con effetti deleteri a livello viscerale e immunitario (Fryer 1999). La clinica e la ricerca, ci insegnano che il trigger disfunzionale a volte proviene da tessuti privi di fusi neuromuscolari come può essere il viscere (Korr 1975). Gli unici recettori periferici presenti nel muscolo in grado di attivare il sistema simpatico sembrano essere le terminazioni nervoso libere (Anmann 2012, Mitchell & Smith 2008).
Van Buskirk partendo dagli studi di Korr e abbracciando la sua visione neurologica, propone che il denominatore comune, ovvero il trigger in grado di scatenare la cascata di eventi che porta alla disfunzione somatica sia il dolore, o meglio le informazioni nocicettive. Il suo modello mette al centro il ruolo delle terminazioni nervose libere, recettori che, pur rispondendo anche ad altri tipi di stimoli, vede come prevalentemente nocicettivi. A seconda dell’entità dello stimolo, dello stato mentale in cui si trova il soggetto, l’informazione nocicettiva potrà arrivare alla corteccia ed essere percepita come un dolore, o rimanere a un livello sottocorticale per essere gestita dai sistemi più arcaici. In un caso o nell’altro, l’attivazione dei nocicettori causa: vasodilatazione, stravaso di fluidi e attrazione di cellule immunitarie, che abbassano ulteriormente la soglia di attivazione dei nocicettori stessi. Questo porta a una retroazione positiva che perpetua il ciclo di disfunzione somatica. I riflessi nocicettivi producono contrazioni muscolari difensive per minimizzare il dolore percepito, causando rigidità e limitazione del movimento.
Attraverso i riflessi nociautomatici, i nocicettori attivano risposte simpatiche che possono includere vasocostrizione, alterazione della motilità gastrointestinale e altri effetti autonomici. Questo può portare a disfunzioni viscerali. L’attivazione cronica del sistema simpatico può anche compromettere la funzione immunitaria, contribuendo a una diminuzione della risposta del sistema immunitario (Van Buskirk 1990).
Il Ruolo della Fascia nella Disfunzione Somatica
Negli ultimi anni, diversi autori italiani hanno contribuito ad allargare gli orizzonti della disfunzione somatica, integrando le nuove scoperte e fornendo possibili meccanismi fisiologici collegati alla sua genesi. Ne è u esempio Paolo Tozzi che attraverso il suo “fasciagenic Model” rimette al centro il ruolo del tessuto connettivo (Tozzi 2015). La fascia rappresenta in effetti un tessuto ubiquitario e dinamico, responsabile della connessione e integrazione delle varie componenti. È descritta come un “organo di forma” e “organo di interiorità”, con proprietà meccaniche e biochimiche che influenzano il comportamento cellulare attraverso la meccano-trasduzione. La disfunzione somatica è attribuita a meccanismi fasciali che coinvolgono alterazioni strutturali (ispessimento, densificazione, fibrosi) e funzionali (riduzione dello scivolamento fasciale e modifiche viscoelastiche). I cambiamenti fasciali possono propagarsi a livello sistemico, causando adattamenti locali e globali.
Sempre più studi hanno chiarito il ruolo sensoriale della fascia, la cui alterazione può influenzare la coordinazione motoria (Stecco 2016). Si è anche scoperto che l’attività simpatica attraverso il rilascio di citochine come il TGF-β1 può determinare la differenziazione dei fibroblasti in miofibroblasti modificando così la densità della fascia e di conseguenza il “human resting myofascial tone”, ovvero il tono fasciale di base in assenza di attività elettromiografica.
L’autore riconosce il ruolo centrale del sistema nervoso in molti aspetti della disfunzione, ma ricorda anche che il tessuto connettivo ha proprietà viscoelastiche intrinseche legate in parte ai domini di coerenza dell’acqua in parte alle capacità piezoelettriche, in grado di influenzare sia la rigenerazione tissutale che la trasmissione di segnali meccanici ed elettrici.
L’Impatto Clinico della Disfunzione Somatica
La fascia diviene il tramite attraverso la quale il trattamento osteopatico può condizionare il sistema nervoso, riducendo il dolore (Cerritelli et al. 2015, Licciardone et al. 2005), modificando l’assetto autonomico (Fornari et al. 2017, Manzotti et al. 2022, Cerritelli 2020), la connettività cerebrale delle aree responsabili del dolore (Tramontano et al. 2020, Tomaiuolo et al. 2024) e modulando la risposta neuro immunitaria (Licciardone et al 2012).
Criteri Diagnostici della Disfunzione Somatica
Oggi l’organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito la Disfunzione Somatica all’interno dell’ICD11, nel gruppo di “lesione biomeccaniche non classificate altrove”, e la definisce come: Funzione danneggiata o alterata di componenti collegate al sistema somatico (struttura del corpo): strutture muscolo scheletriche articolari, miofasciali e gli elementi vascolari, linfatici e nervosi associati.
I Criteri diagnostici per la disfunzione somatica sono identificati dalla palpazione e possono essere richiamati alla memoria con l’acronimo TART
T. Anomalia nella trama tissutale
A. Asimmetria
R. Restrizione di movimento,
T. Tenderness – sensibilità palpatoria
Prospettive Future nella Ricerca
Nel 2022 un altro gruppo italiano ha prodotto una revisione con lo scopo di valutare la centralità della disfunzione somatica all’interno degli studi clinici in ambito osteopatico. Dei 280 selezionati, solo 170 consideravano la disfunzione somatica come criterio diagnostico. Sorprendentemente solo il 15,8 % degli studi esaminati utilizzava il criterio TART per la diagnosi o quanto meno lo specificava nello studio e fatemi fare un po’ di campanilismo, molti di questi erano italiani (Tramontano et al. 2022). Ciò che dovrebbe essere il fulcro del trattamento manuale osteopatico, a volte non viene preso neanche in considerazione per effettuare la diagnosi, molte altre volte ahimè non ci troviamo d’accordo sui criteri utilizzati per diagnosticarla. È imperativo rimettere al centro della ricerca la disfunzione somatica, per ciò che concerne i meccanismi fisiologici che la causano, l’affidabilità tra operatori ma soprattutto il suo valore diagnostico nell’ambito clinico.
Abbiamo analizzato la disfunzione somatica da diverse prospettive, ma il dibattito è sempre aperto. Quali aspetti ritenete più cruciali per il futuro della ricerca in questo campo? Lasciate un commento!
Simone Bagatti D.O.
Bibliografia
Anmann M. Significance of group III and IV muscle afferents for the endurance execising in human. Proc Aust Physiol Soc 2012 43, pp. 1-7
Burns, L. Viscerosomatic and somatovisceral spinal reflexes. JAOA. 1907 7:51-7.
Cerritelli F, Ginevri L, Messi G, Caprari E, Di Vincenzo M, Renzetti C, Cozzolino V, Barlafante G, Foschi N, Provinciali L. Clinical effectiveness of osteopathic treatment in chronic migraine: 3-Armed randomized controlled trial. Complement Ther Med. 2015 Apr;23(2):149-56
Cerritelli F, Cardone D, Pirino A, Merla A, Scoppa F. Does Osteopathic Manipulative Treatment Induce Autonomic Changes in Healthy Participants? A Thermal Imaging Study. Front Neurosci. 2020 Aug 18;14:887.
Denslow JS, Korr IM, Krems AD: Quantitative studies of chronic facilitation in human motoneuron pool. Am J Physiol 1947;105:229-238.
Korr IM: The neural basis of the osteopathic lesion. JAOA 1947;191-198.
Korr IM. Symposium on the functional implications of segmental facilitation; a research report. I. The concept of facilitation and its origins. JAOA 1955 Jan;54(5):265-8
Korr IM: Proprioceptors and somatic dy sfunction. JAOA 1975;638-650.
Korr IM, Wright HM, Thomas PE : Effects of experimental myofascial insults on cutaneous patterns of sympathetic activity in man. J Neural Transm 1962 ;23:330-355.
Licciardone JC, Kearns CM, Hodge LM, Bergamini MVW. Associations to Cytokine Concentrations With Key Osteopathic Lesions and Clinical Outcomes in Patients With Nonspecific Chronic Low Back Pain: Results from the OSTEOPATHIC Trial. JAOA 2012; 112(9): 596-605
Licciardone JC, Brimhall AK, King LN. Osteopathic manipulative treatment for low back pain: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Musculoskelet Disord. 2005 Aug 4;6:43. doi: 10.1186/1471-2474-6-43. PMID: 16080794; PMCID: PMC1208896.
Mitchell JH, Smith SA. Unravelling the mysteries of the exercise pressor reflex at the cellular level. J Physiol. 2008 Jul 1;586(13):3025-6. doi: 10.1113/jphysiol.2008.157164. PMID: 18593887; PMCID: PMC2538775.
Stecco A, Stern R, Fantoni I, De Caro R, Stecco C. Fascial Disorders: Implications for Treatment. PM R. 2016 Feb;8(2):161-8. doi: 10.1016/j.pmrj.2015.06.006. Epub 2015 Jun 14. PMID: 26079868.
Tozzi P. A unifying neuro-fasciagenic model of somatic dysfunction – underlying mechanisms and treatment – Part I. J Bodyw Mov Ther. 2015 Apr;19(2):310-26. doi: 10.1016/j.jbmt.2015.01.001. Epub 2015 Jan 19.
Tomaiuolo F, Cerritelli F, Delli Pizzi S, Sestieri C, Paolucci T, Chiacchiaretta P, Sensi SL, Ferretti A. Data-driven analysis of whole-brain intrinsic connectivity in patients with chronic low back pain undergoing osteopathic manipulative treatment. Neuroimage Clin. 2024;43:103659. doi: 10.1016
Tramontano M, Tamburella F, Dal Farra F, Bergna A, Lunghi C, Innocenti M, Cavera F, Savini F, Manzo V, D’Alessandro G. International Overview of Somatic Dysfunction Assessment and Treatment in Osteopathic Research: A Scoping Review. Healthcare (Basel). 2021 Dec 24;10(1):28.
Van Buskirk RL. Nociceptive reflexes and the somatic dysfunction: a model. J Am Osteopath Assoc. 1990 Sep;90(9):792-4, 797-809.