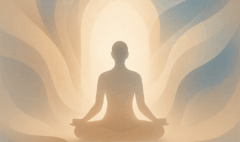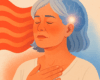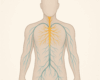Garrincha e la Compensazione Creativa: La Trasformazione dell’Inferiorità in Arte
Garrincha e la Compensazione Creativa: La Trasformazione dell’Inferiorità in Arte
La Bellezza della Trasformazione
Accade talvolta nella stanza di psicoterapia che accanto al sintomo, alla sofferenza, alla ripetizione, affiori una forma misteriosa di bellezza che non coincide con la guarigione né con l’assenza di conflitto, ma che si mostra nel modo in cui il soggetto, pur attraversato dalla ferita, riesce a farne gesto, forma, stile. Per comprendere davvero il valore di questa rivelazione è necessario precisare che la clinica non è mai il luogo della correzione, ma della trasformazione.
Durante gli anni della mia formazione come psicoterapeuta, molte immagini mi sono state offerte come strumenti di orientamento, come figure emblematiche capaci di educare lo sguardo clinico a riconoscere l’irriducibile singolarità del soggetto. Tra queste, una continua a tornare con forza, come una traccia che insiste nel tempo della memoria: è l’immagine di Garrincha. Non solo campione imperfetto, come semplice icona sportiva, ma come paradigma vivente della teoria adleriana della compensazione.
Credo rappresenti un’occasione clinica importante per il terapeuta riuscire a incontrare almeno un “Garrincha” nel proprio percorso: un paziente che, segnato nel corpo o nella storia, ha saputo danzare sulla propria stortura, trasformando il difetto in creazione. Non si tratta di celebrare l’eroismo, né di mitizzare il dolore, piuttosto, di riconoscere che la soggettività, come ci insegna Adler, non si costruisce contro il limite, ma attraverso il limite e che in quella tensione tra vulnerabilità e invenzione si gioca la possibilità più autentica di un’esistenza umana. Garrincha, nella sua paradossale armonia di imperfezione e grazia, ci offre un’immagine viva di questa possibilità.
Garrincha e la sua arte calcistica unica
Adler è stato il primo, tra i grandi padri della psicoanalisi, a collocare al centro della dinamica psichica non il desiderio sessuale (come Freud), ma la ferita del sentimento di inferiorità. Secondo la sua teoria l’essere umano è strutturalmente mancante, inadeguato, carente ed è proprio questa mancanza che diventa il motore della sua crescita. “Tutto ciò che chiamiamo cultura, civiltà, conquista,” scrive Adler, “nasce da un sentimento di inferiorità superato” (Il senso della vita, 1933).
Nel caso di Garrincha, questa ferita non è simbolica o nascosta: è visibile, concreta, esibita dal corpo stesso. Le gambe storte, la deambulazione irregolare, la sproporzione tra le parti. Un corpo che sembrava gridare l’impossibilità di qualsiasi forma di prestazione sportiva. E tuttavia, proprio da quella ferita corporea, Garrincha ha prodotto una delle forme più libere e inventive del gioco del calcio. Non ha negato il limite: lo ha danzato, non ha corretto la deviazione: l’ha trasformata in stile. Questa è la compensazione nella sua forma creativa non come difesa, ma come gesto di soggettivazione.
Il Paradosso della Compensazione
Manuel Francisco dos Santos, per tutti Garrincha, nacque con un corpo sbagliato. Una gamba più corta dell’altra di sei centimetri. Il ginocchio sinistro che fletteva verso l’interno, il destro verso l’esterno. Per molti, la sua forma gli aveva consegnato un destino già segnato: irriso dai medici, scartato dagli allenatori, compatito da chi vede nel corpo soltanto la sua utilità funzionale. Eppure, proprio da quella menomazione prese corpo la danza più sfuggente e sublime che il calcio ricordi: Garrincha non dribblava come gli altri, non correva come gli altri, non era come gli altri e proprio per questo fu irripetibile.
La psicoanalisi adleriana offre una chiave profonda per leggere questo paradosso. Alfred Adler, nei suoi studi fondamentali (Il temperamento nervoso, 1912; La conoscenza dell’uomo, 1927), ha parlato del sentimento di inferiorità come del motore invisibile che spinge l’uomo oltre sé stesso. Da questa prospettiva non parliamo di un limite da correggere, ma di una mancanza che, se attraversata e trasformata, diventa spinta creativa. La compensazione, in Adler, è il tentativo, spesso inconsapevole, di rispondere a una ferita originaria non con la resa, ma con l’invenzione e così è stato per Garrincha.
La Tragedia della Ipercompensazione
Garrincha, zoppo per la medicina, danzava con una leggerezza che sfidava la gravità e faceva sì che nessuno riuscisse a prevedere le sue traiettorie non per caso, ma per struttura. Era il suo stesso corpo ad essere imprevedibile e in questo si realizza la più autentica compensazione: non il desiderio di normalità, ma la trasformazione dell’anomalia in dono. Garrincha non correva nonostante la sua deformità, ma attraverso di essa.
Eppure, la vita dell’angelo zoppo fu anche tragica. Dopo le glorie mondiali, la sua parabola discese nell’abisso: alcol, solitudine, ospedali pubblici, la morte dimenticata. Anche questa dolorosa fine ci offre spunti di riflessione se pensiamo che la compensazione, per Adler, può anche eccedere diventando ipercompensazione, maschera, difesa narcisistica che implode quando non è sostenuta da un progetto etico, da un legame autentico con il mondo e con l’altro.
Conclusioni e Riflessioni Finali
Nel caso di Garrincha, possiamo intuire entrambi i movimenti: sul campo, il corpo zoppo diventa leggerezza pura, beffa, gioco come il regno della compensazione creativa ma fuori dal campo, nella sua vita intima, affettiva e relazionale, quell’equilibrio si spezza. Il corpo non danzante, il corpo non visto, precipita nel vizio e nella solitudine, in una forma di autodistruzione che ha il sapore amaro dell’ipercompensazione fallita.
Come psicoterapeuti, impariamo che il punto non è eliminare la mancanza, ma farci qualcosa. Il lavoro analitico, come la vita di Garrincha, ci mostra che esiste una differenza radicale tra negare il difetto e lavorarlo simbolicamente: Garrincha ha saputo fare del suo corpo una forma d’arte ma là dove la compensazione non ha trovato una parola, un legame, un contenitore, si è rovesciata nella sua ombra.
Garrincha rimane per me un’immagine che illumina: mi ricorda che l’anomalia non è sempre un errore da correggere ma può diventare anche un’opera in potenza. Tuttavia avverte, allo stesso tempo, del rischio del collasso, quando la forma non regge più la tensione della ferita. E allora il compito analitico non è guarire, ma custodire: proteggere il gesto, restituire parola alla mancanza, impedire che il talento diventi prigione.
Francesca Durante, Psicologa e Psicoterapeuta