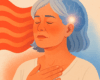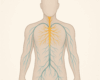Allenarci a riposare: il percorso della mindfulness
Allenarci a riposare: il percorso della mindfulness
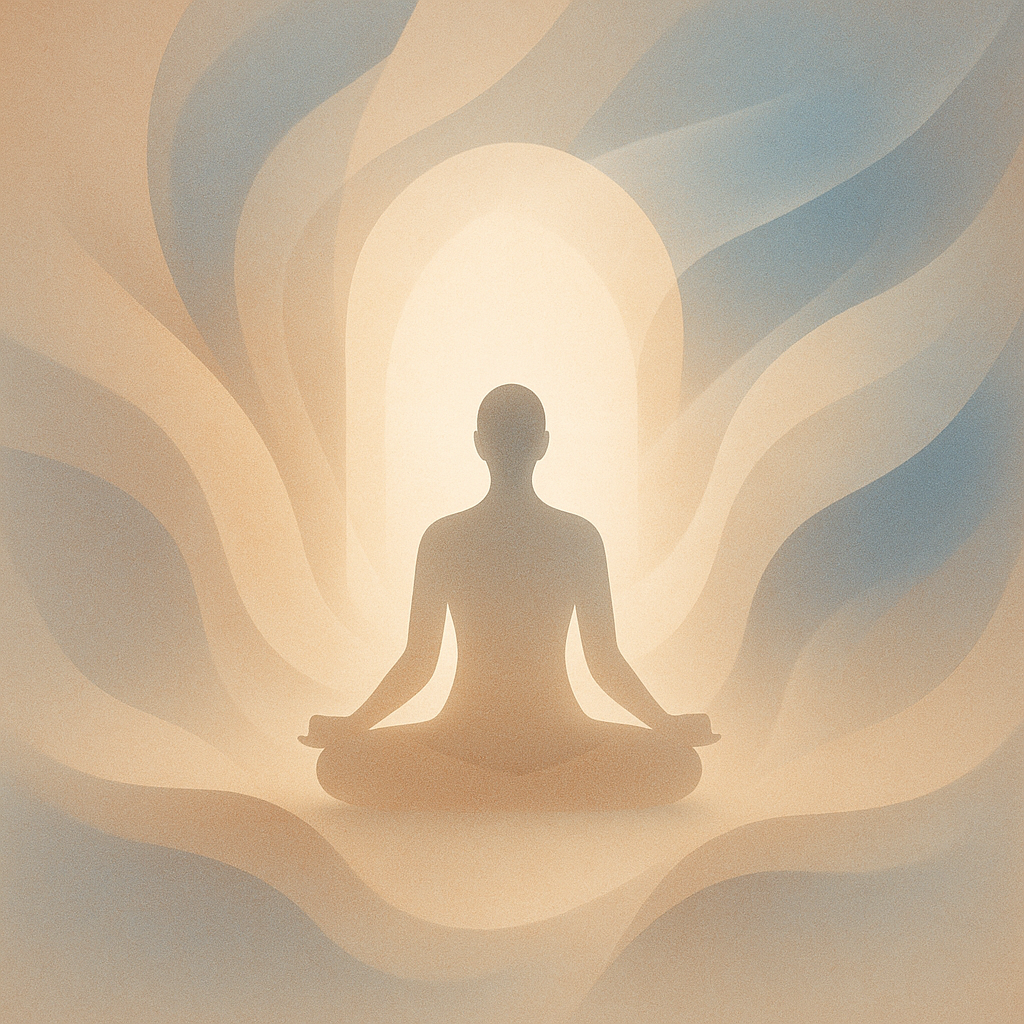
A cura di Roberto Ferrari, biologo e Mindfulness trainer
Sono molti gli studi che hanno cercato di chiarire i meccanismi attraverso i quali agisce la disciplina della Mindfulness, spesso tradotta come “presenza mentale” o “meditazione di consapevolezza”, una pratica semplice ed efficace di cura di sé che ha sempre maggiore applicazione in ambiti clinici, professionali ed educativi. In realtà, esistono diversi approcci basati su questa pratica, ma il più noto, scientificamente validato e diffuso resta il protocollo MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction). Una importante pubblicazione di Shapiro e Carson (J.Clin.Psychol., 2006) ha individuato tre elementi sottostanti al modo in cui “funziona” la Mindfulness.
Intenzione, attenzione, non giudizio
Intenzione. È necessaria una motivazione interna chiara, una percezione di cosa desideriamo, quali sono i nostri bisogni e le nostre priorità. Non c’è bisogno di esplicitarli, ma è importantissimo sentirli, sentire il desiderio di stare bene: l’intenzione è un atto di consapevolezza che orienta e rende limpido il cammino. Per questo intraprendere la Mindfulness è un percorso che non può essere reso obbligatorio, ma nasce da una spinta ed esigenza interiore. L’intenzione è la nostra guida a praticare con costanza.
Attenzione. Un’attenzione che si esercita nel momento presente, come un muscolo da allenare. Non ha a che fare con una comprensione intellettuale ma con una pratica di ascolto delle sensazioni del corpo, del respiro, dei suoni e dello spazio che ci circonda. Questa capacità attentiva favorisce calma e lucidità, e ci permette di riconoscere quando emergono schemi automatici di comportamento che non ci aiutano, ci confondono e possono rivelarsi disfunzionali. Senza indagarli troppo, ci limitiamo a notarli con uno specifico atteggiamento: ed ecco il terzo elemento.
Non giudizio. È un’attitudine che emerge con la pratica: la sospensione che accade in certi momenti di lucidità, quando la mente si ferma di fronte alla natura, a un’emozione forte o a un incontro significativo. In quei frangenti c’è un silenzio di fondo che ci permette di osservare l’emergere dei nostri schemi mentali rigidi, delle opinioni e delle narrazioni interiori. Li possiamo guardare senza pesarli, senza valutarli, riconoscendoli come transitori. Non ci definiscono.
Disaccoppiare dolore da sofferenza
Questa è, in una brevissima sintesi, la dinamica della mindfulness. Come è facile notare, questi elementi operano non su specifici contenuti individuali ma su processi mentali che, sia dal punto di vista neurofisiologico che esperienziale, sono comuni a tutti.
Gli studi sui pazienti con dolore cronico lo mostrano con chiarezza: dopo un certo periodo di addestramento, i pazienti meditanti riescono a disaccoppiare le aree cerebrali della percezione diretta del dolore fisico da quelle responsabili della sofferenza aggiuntiva che si manifesta come reattività emotiva e ruminazioni automatiche (Grant et al., Pain, 2011). Raccontarci il dolore può essere utile, perché la narrazione è un comportamento adattativo, ma talvolta diventa una spirale ripetitiva e inefficace. La pratica, invece, apre la possibilità di distinguere tra la percezione diretta del dolore e narrazione della sofferenza, creando uno spazio libero da previsioni catastrofiche, e in cui cogliere, ad esempio, che il dolore non è continuo, ha pause e pulsazioni.
Il punto che più mi interessa sottolineare è che allenarci a questo disaccoppiamento significa allenarci a riposare davvero, in quella dimensione che possiamo indicare con la metafora dello “spazio libero”. Non parlo di pigrizia, ma di un riposo profondo che nasce dal non fare nulla al di fuori di ciò che accade. Riposare significa non opporsi, non resistere. E sappiamo bene che, tanto nel dolore fisico quanto in quello morale o esistenziale, opporsi significa spesso prolungarlo ed esacerbarlo.
Riposare è cambiare radicalmente strategia: addestrarsi giorno dopo giorno a connettersi al proprio sentire e scoprire uno spazio più vasto, uno spazio che siamo e che contiene forme, sensazioni, idee, sorprese e leggerezza. Lì, o meglio qui, possiamo finalmente dirci: “Non è grave”. Possiamo smettere, almeno per un periodo, di sforzarci di costruire significati, di trarre conclusioni, di tenere insieme tutto il nostro mondo di convinzioni, il che richiede una grande fatica.
Danza ai confini del caos
In questo spazio talvolta ci sono elementi un po’ disordinati e difficili, perché noi siamo allo stesso tempo ordine ed entropia: una danza ai confini del caos. Come biologo, trovo in questa immagine una delle più efficaci definizioni della vita. Donarci il tempo di riposare in questo sfondo di esperienza diretta ci fa percepire che dolore, tristezza o preoccupazione ci sono, ma non sono tutto. Possiamo osservare come sorgono e come si dissolvono, senza voler sempre correggere, eliminare o migliorare. È uno spazio di accoglienza, spensierato ma rispettoso, che non minimizza la sofferenza: la riconosce e le permette di esistere senza frantumarci.
Lo spazio interiore della consapevolezza non riguarda solo noi stessi. Ha un effetto profondo anche sulle relazioni: possiamo offrire agli altri uno spazio aperto, senza agende o aspettative, senza irrigidire i rapporti o appesantirli con giudizi. Sono interventi sottili, come quelli di chi lavora sul corpo: movimenti, che facilitano e aprono, attivano dinamiche di guarigione senza pretendere di controllare ogni istante.
Compassione
Qui entra in gioco un altro elemento essenziale della mindfulness: la compassione. So che in italiano la parola può suonare ambigua e pesante, ma nel suo senso autentico significa semplicemente “sentire con l’altro”. Io preferisco intenderla come ospitalità, come gentilezza, un gesto del cuore. È un impegno alla chiarezza e alla partecipazione, privo di ego o di narcisismo. Non è il ruolo del salvatore che si fa carico della sofferenza altrui, serioso, grave.
La compassione è la presenza rilassata di chi non prende le cose troppo sul serio, resta aperto a vasto dentro, e proprio per questo può avvicinarsi con delicatezza a chi soffre. È un atteggiamento che prende atto che alcuni esseri ora sono felici, altri soffrono moltissimo, e questa sofferenza ora sorge, ora si dissolve: è quello che c’è, e facciamo il meglio che possiamo per affrontarla. Senza prendere troppo sul serio qualcuno, o se stessi, perché questo è già emettere una pesante valutazione, mentre l’atteggiamento della mindfulness, abbiamo detto, è quello del non giudizio.
Essere compassionevoli credo significhi proprio dare ospitalità a quello che c’è, in noi e negli altri: restare aperti e capaci di rispondere – questa è la responsabilità – in modo flessibile e morbido.
Un invito al riposo
Perciò, la prossima volta che vogliamo riposare, possiamo semplicemente sederci immobili per qualche respiro, aprire la mente e lasciarla com’è. Non c’è bisogno di controllarla o migliorarla, né di respingere ciò che arriva. Restiamo presenti alla nostra esperienza, con dolcezza: nelle parole di quel grande insegnante di meditazione Vipassana che è stato Corrado Pensa, da poco scomparso, “meditare è una attenzione affettuosa”.
Se sorgono domande o dubbi, se tocchiamo un nostro nervo scoperto, non sono ostacoli, ma doni della pratica: sorprese che ci rivelano qualcosa di nuovo.
La mindfulness, in fondo, è un semplice invito al riposo nella consapevolezza: un riposo che accoglie, alleggerisce e, al tempo stesso, ci rende più vivi e più attenti.
Bibliografia e autore
Roberto Ferrari, biologo, ha svolto per trent’anni attività di ricerca nel campo dell’etologia cognitiva presso l’Università di Bologna. È docente di Mindfulness al Master dell’Università La Sapienza di Roma, insegna presso la Scuola di Psicoterapia “Nous” di Milano e la Scuola Superiore di Filosofia Orientale e Comparativa di Rimini. Ha fondato il Centro Mindfulness “Mente&Vita” dell’Associazione AsiaModena, operando all’interno di progetti di ricerca sulla Mindfulness in ospedali con pazienti oncologici e personale sanitario, in scuole e carceri.
- Un respiro alla volta. Storie di mindfulness in Oncologia e tra gli animali (Pendragon, Bologna 2021)
- Meditare con gli animali. 8 esercizi di mindfulness nella natura (Laterza, Roma-Bari 2025)