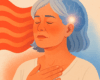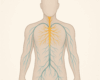Morbo di Osgood-Schlatter: aggiornamento clinico, fisiopatologia, gestione conservativa e possibile ruolo del trattamento osteopatico
Morbo di Osgood-Schlatter: aggiornamento clinico, fisiopatologia, gestione conservativa e possibile ruolo del trattamento osteopatico

Introduzione
Il morbo di Osgood-Schlatter (OSD) è una delle cause più frequenti di dolore anteriore di ginocchio nell’età evolutiva. È classicamente descritto come un’apofisite da trazione della tuberosità tibiale durante la crescita, legata a carichi ripetuti sull’unità muscolo-tendinea quadricipitale-tendine rotuleo.
Negli ultimi anni la letteratura ha affinato sia la comprensione eziopatogenetica (non solo “trazione” ma anche rimodellamento apofisario, fattori biomeccanici e di carico) sia gli approcci di gestione centrati su educazione, modulazione del carico ed esercizio. In questo quadro, sono emerse domande pragmatiche su terapie complementari – incluso il trattamento manipolativo osteopatico (OMT) – e sul loro potenziale ruolo. Questo contributo offre una sintesi discorsiva e critica delle evidenze su definizione, epidemiologia, insorgenza, fattori di rischio e trattamento dell’OSD, seguita da una valutazione onesta e basata sui dati del possibile impiego dell’OMT.
Definizione ed epidemiologia
L’OSD è una condizione correlata alla crescita (apofisite della tuberosità tibiale) che insorge tipicamente tra i 10 e i 16 anni. Colpisce fino a ~10% degli adolescenti fisicamente attivi, con prevalenza maggiore tra chi pratica sport “esplosivi” (salti, sprint, cambi di direzione). Il classico picco maschile riportato nei testi più datati sembra essersi attenuato negli ultimi anni, probabilmente per l’aumento della partecipazione femminile a sport ad alto impatto: oggi la distribuzione di sesso è più equilibrata nei campioni sportivi. La storia naturale è di solito autolimitante, ma in una quota non trascurabile i sintomi possono persistere o lasciare residui (dolorabilità alla pressione, nodulo osseo) anche in età adulta, specialmente in chi continua attività ad alto impatto senza adeguata modulazione del carico.
Fisiopatologia e insorgenza
L’analisi della fisiopatologia ha rilevato che gli stress ripetuti sul nucleo di ossificazione della tuberosità tibiale, durante fasi di rapido accrescimento, generano micro-danni e risposte di rimodellamento con edema apofisario e ispessimento del tendine rotuleo prossimale. A contribuire sono: aumento brusco dei volumi/intensità di allenamento, leve sfavorevoli (angolo Q, torsioni tibiali), deficit di forza e controllo eccentrico del quadricipite e della catena posteriore, nonché fattori di maturazione (età ossea vs cronologica). Studi recenti sottolineano alterazioni biomeccaniche del gesto e del controllo neuromuscolare nei soggetti con OSD, aprendo la strada a interventi mirati su carico e tecnica.
Fattori di rischio
I determinanti meglio documentati includono:
- Carico eccessivo/rapidi aumenti di esposizione a salti, sprint, cambi di direzione.
- Età di picco di crescita (PHV): finestra di vulnerabilità per tessuti apofisari.
- Sport specifici (calcio, basket, atletica, ginnastica).
- Deficit di forza/controllo del quadricipite (soprattutto in eccentrica) e dell’anca, ridotta flessibilità quadricipite/ischiocrurali.
- Pattern biomeccanici (p. es. tendenza a “quad-dominance”, atterraggi rigidi, valgismo dinamico).
Una rassegna sistematica del 2022 ha sintetizzato i principali fattori predisponenti, evidenziando la centralità del carico e l’interazione con la maturazione scheletrica.
Valutazione clinica e diagnosi
La diagnosi è clinica: dolore localizzato sulla tuberosità tibiale evocato da corsa, salti, inginocchiamento; test funzionali (squat, step-down, salti) riproducono i sintomi. L’ecografia può documentare ispessimento del tendine rotuleo prossimale e alterazioni apofisarie; la radiografia è raramente necessaria (diagnosi differenziale o ossicoli dolorosi). Scale come KOOS-Child e VAS supportano il monitoraggio.
Trattamento:
Educazione e modulazione del carico
Evitare l’astensione totale prolungata: preferire “attività a gradini”, con criteri di progressione basati su dolore ≤3/10 durante e dopo l’attività e assenza di incremento dei sintomi il giorno successivo. In uno studio prospettico su 51 adolescenti, un programma di 12 settimane centrato su educazione, modifica del carico ed esercizio ha portato l’80% a un esito “di successo” a 12 settimane (90% a 12 mesi).
Esercizi terapeutici
Vengono consigliati generalmente esercizi di tipo isometrico, in particolare del quadricipite per analgesia nelle fasi dolorose; eccentrici/concentrici lenti per caricare progressivamente l’unità tendinea; di rinforzo di anca e core, per controllo del valgismo dinamico e mobilità mirata di quadricipite e catena posteriore, con stretching dosato secondo sintomo.
Ausili e analgesia
Fasce sottorotulee/taping possono ridurre il carico sul tratto prossimale del tendine rotuleo; utilizzo di FANS per brevi periodi nei picchi algici nonostante l’evidenza sia di qualità moderata/bassa ma la sicurezza è buona se ben dosati.
Interventi invasivi o “alternativi”
Infiltrazioni (salina, destrosio/proloterapia, PRP): la letteratura è crescente ma di qualità complessivamente bassa-moderata, con studi non randomizzati; un lavoro del 2024 su LR-PRP ha riportato miglioramenti clinici, ma la generalizzabilità è limitata. L’uso routinario non è raccomandato come prima linea. Medscape+1
Immobilizzazione: trial registrati hanno confrontato tutori/immobilizzazione con riposo sportivo; è una strategia possibile nelle fasi iper-algiche ma da limitare per evitare decondizionamento. ClinicalTrials
Chirurgia: riservata a rari casi con ossicoli dolorosi persistenti a maturazione scheletrica completata. PMC
Prognosi e impatto funzionale
Sebbene l’OSD sia spesso autolimitante, la durata dei sintomi può estendersi a mesi; alcuni adolescenti mantengono alti livelli di attività pur con dolore e funzione ridotta, suggerendo la necessità di interventi che non puntino solo al “riposo” ma alla gestione del carico e al supporto psicosociale.
Trattamento osteopatico (OMT): quale ruolo?
Razionale biomeccanico
In OSD la trasmissione di carichi attraverso il complesso quadricipite-tendine rotuleo può essere influenzata da tensioni miofasciali, schemi di movimento “quad-dominant”, alterazioni di bacino/anca e catena cinetica. Tecniche OMT (rilascio miofasciale, inibizione dei trigger points, tecniche ad energia muscolare su quadricipite/ischiocrurali, mobilizzazioni femoro-rotulee/tibio-femorali dolci, approcci indiretti fasciali) mirano a ridurre ipertono e migliorare il pattern di carico, facilitando l’esercizio terapeutico e la rieducazione del gesto.
L’evidenza scientifica hasegnalato uno studio randomizzato di piccole dimensioni (30 ragazzi, 10–15 anni) in cui l’OMT aggiunta a un programma riabilitativo standard ha mostrato benefici su dolore e funzione rispetto alla sola riabilitazione. Altri studi basati su condizioni affini hanno dimostrato come l’OMT può essere una soluzione integrativa nella gestione della patologia; tra questi è stata analizzata l’efficacia dell’OMT su dolore femoro-rotuleo (PFPS) nei giovani: una meta-analisi RCT (2024) su OMT ha rilevato riduzioni del dolore rispetto ai controlli in 3 studi, con effetti piccoli-moderati ed eterogeneità.
Allo stato attuale è quindi ragionevole considerare l’OMT come co-intervento within-session per modulare il dolore a breve termine e ottimizzare l’aderenza agli esercizi.
Conclusioni
Il morbo di Osgood-Schlatter è un disturbo da crescita e carico: educazione, modulazione del carico ed esercizio terapeutico rappresentano i pilastri della cura, con prove crescenti a loro favore. Gli interventi osteopatici possono avere un ruolo complementare come strumento di analgesia a breve termine e facilitazione del movimento, utile a potenziare l’aderenza al programma riabilitativo.
Irene Vecchi D.O.
Bibliografia
- Corbi F, Matas S, Álvarez-Herms J, et al. Osgood-Schlatter Disease: Appearance, Diagnosis and Treatment – A Narrative Review. Healthcare. 2022;10(6):1011. PMC+1
- Lucenti L, et al. The Etiology and Risk Factors of Osgood–Schlatter Disease. J Clin Med. 2022;11(12):… PMC
- Neuhaus C, et al. A systematic review on conservative treatment options for Osgood-Schlatter disease. Phys Ther Sport. 2021;49:… ScienceDirect+1
- Rathleff MS, et al. Activity Modification and Knee Strengthening for Osgood-Schlatter Disease. Orthop J Sports Med. 2020;8(4):2325967120911106. PMC+1
- Krommes K, et al. Self-management including exercise, education and activity modification… (SOGOOD trial protocol). BMC Sports Sci Med Rehabil. 2024. BioMed Central
- ClinicalTrials.gov. NCT05174182 – A Comparison of Two Different Treatment Approaches for OSD (SOGOOD). Protocol/SAP (2024). cdn.clinicaltrials.gov
- StatPearls. Osgood-Schlatter Disease. Updated 2023. NCBI
- Medscape. Osgood-Schlatter Disease – Treatment & Management. Updated 2024. Medscape
- Guszczyn T, et al. Effectiveness of LR-PRP in OSD. J Clin Med. 2024;… PMC
- ClinicalTrials.gov. NCT02824172 – Immobilization vs Rest in OSD. ClinicalTrials
- Malliaras P, et al. Patellar Tendinopathy: Diagnosis & Load Management. JOSPT. 2015;45(11):… (principi di carico utili per OSD). jospt.org
- Delgadillo BE, et al. Efficacy of OMT for PFPS: Meta-analysis of RCTs. (2024). PMC+1
- Altınbilek T, et al. OMT vs Exercise in Knee OA: RCT. Turk J Phys Med Rehabil. 2018;64(2):114-120. PubMed+1
- “Assessment of osteopathic treatment efficacy… in acute OSD (randomized).” Abstract repository (2025). ResearchGate
- Biomechanical alterations in OSD: Systematic Review (2025). Taylor & Francis Online
Rathleff MS, et al. Pain, Sports Participation, and Physical Function in Adolescents With OSD/PFPS. JOSPT. 2020;50(3):… jospt.org